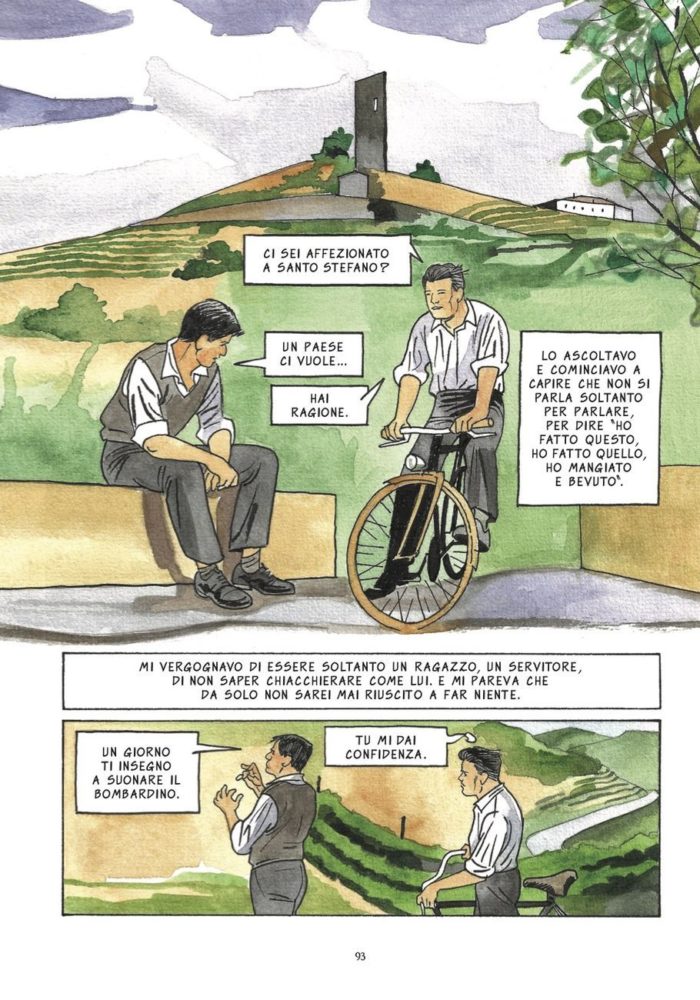Scrivo queste righe in occasione dei miei 30 anni. Penso sia un modo per esorcizzarne l’arrivo.
Chi mi conosce sa bene che non amo molto festeggiare, soprattutto quando la ragione della festa è qualcosa a cui ho contribuito poco. In fin dei conti, compiere gli anni è ciò che fai mentre provi a fare altro. In altre parole, il raggiungimento degli anni è solo parte del contesto e il contesto è fatto per scorrere sullo sfondo mentre gli attori vanno in scena.
Non ho idea di quanti anni ancora scorreranno sullo sfondo ma, raggiunto il trentesimo atto, mi chiedo verso quale direzione stia proseguendo la regia e la sceneggiatura della mia opera teatrale.
Sono successe molte cose nei miei “anni 20”, tra queste: mi sono trasferito in una nuova città, allontanandomi da ciò che fino a quel momento avevo costruito e allungando le distanze che mi separavano dai miei affetti; ho vissuto amori e infatuazioni fallimentari; ho provato cosa significa l’isolamento forzato, in una stanza di 15 metri quadri, senza alcun contatto fisico o una parola che non fosse scambiata senza l’intercessione del telefono; ho fatto e continuo a fare un mestiere che, ai tempi dell’università, giuravo di non voler fare mai.
Eppure, mi accingo a svolgere questo esercizio esorcizzante (mi scuserete per lo scioglilingua), non per parlare di quello che ho fatto, ma di quello che ho capito. Perché se c’è una cosa che ritengo importante, per vivere bene e non sprecare neanche un singolo giorno, è quello di abbandonare la supponenza di chi crede di sapere sempre come vanno le cose e che non ci sia nulla da imparare da ciò che ti succede attorno. Meglio sentirsi sempre su un banco di scuola e non dare mai nulla per scontato, che essere davanti alla lavagna e fare la figura del somaro.
Le esperienze che viviamo sono importanti anche e soprattutto per consentirci di arrivare più preparati alle prossime. Che poi, a pensarci, è una rielaborazione della teoria inflazionata del perché sia importante studiare la Storia.
Mi presento, dunque, al checkpoint dei 30 anni con qualche sasso in più nelle tasche.
Amare è difficile ma inevitabile. Ho scontato l’insopportabile sensazione che amare fosse qualcosa di insostenibile e di difficile realizzazione. Qualcosa che ormai non avrebbe più toccato le corde della mia esistenza. Lasciare, essere lasciati, lasciarsi vicendevolmente. A seconda di quale fosse la mano che impugnava il fendente, la luce che ha illuminato le diverse scenografie ha concesso un punto di vista unico in ognuno di quei momenti. Come un gioco di logica, unendo quei puntini vien tracciato un disegno in cui oggi mi ritrovo: amore e raziocinio sono uno l’antitesi dell’altro. Non siamo noi che decidiamo di amare, né tantomeno possiamo fuggire dal farlo. Possiamo essere superficiali nei nostri rapporti o, meglio, possiamo resistere ai rapporti superficiali per un certo tempo ma, presto o tardi, tutto crollerebbe per mostrare ciò che realmente è. Nel bene o nel male. Non possiamo simulare di amare una persona né, tantomeno, possiamo imporci dei limiti nel farlo.
Non bisogna dimenticare, ovviamente, che per quanto amare sia inevitabile e allo stesso tempo ingovernabile, anche questo sentimento può finire e la sua esistenza (e persistenza) non può essere data per scontata. Come direbbero quelli bravi: l’amore va coltivato, ogni giorno.
Quando un rapporto con una persona finisce, possiamo sentirci sollevati, o sprofondare nell’assoluta tristezza, ma il fallimento rimane e del fallimento non si butta via nulla. Neanche un solo grammo del fallimento va sprecato. Avendo fallito tante volte, ho capito come non sia possibile far finta che l’amore verso una persona esista, così come non potrei far finta del contrario. È il concetto stesso di protezione nei confronti dei propri sentimenti ad essere ossimorico: cercare protezione da tutto ciò che rientra nell’area semantica dei sentimenti è come cercare riparo da ciò che può ripararci da tutto il resto. È l’assenza dei sentimenti ad esporci a rischi e pericoli, tra cui il più pericoloso: vivere in modo asettico, senza alti e bassi, privo di qualsiasi sensazione che ci faccia sentire più di un insieme di azioni meccaniche come dormire, mangiare, respirare, andare di corpo e tornare a dormire.
Che dispendio inutile di energie sarebbe quello di alzare barriere per ripararci da un improvviso coup de foudre? Parametri vitali al massimo, respiro profondo e muscoli tesi. Tutto è pronto per reagire ad un possibile incontro ravvicinato del terzo tipo. Non l’avrai vinta, mio acerrimo nemico! Eppure, finisci per capitolare appena i tuoi occhi cadono su una persona che, assorta nei suoi pensieri, è seduta in fondo ad una fila di sedie in un’aula di tribunale, mentre è lì per tutt’altro, proprio come te. Per dire.
Non si vive senza abbracci. La Pandemia da Covid-19 ha spinto tutti noi ad interrompere le nostre relazioni umane nella loro dimensione fisica. Ho vissuto intere settimane da solo, a Roma, avendo a disposizione solo una stanza, un minuscolo bagno e una piccola cucina. Insieme a me non c’era nessuno e la cassiera del supermercato in cui andavo a fare la spesa, una volta ogni 10 giorni, era schermata da plexiglass, occhiali e mascherina.
Per la prima volta, mi sono sentito un soggetto pericoloso e schivato, a cui veniva negato il contatto fisico. Ne sono uscito a pezzi e quei pezzi li ho rimessi insieme con il tempo, anche grazie alla psicoterapia.
Se c’è una cosa che ho compreso da quell’esperienza, e che oggi riempie quel vuoto che aveva creato, è la consapevolezza di non poter vivere senza nessuno accanto, fosse anche con la sola idea di poter abbracciare qualcuno alla prima occasione utile. Ho capito di avere estremamente bisogno del contatto fisico.
Per la rubrica “ce lo dice la scienza”: gli abbracci alleviano i sintomi dello stress, aiutano a ridurre la pressione arteriosa e a equilibrare i nostri modi di fare. Non dimentichiamoci, tra le altre cose, che i bambini appena nati aggrappano la propria esistenza al contatto fisico e privargliene implicherebbe condannarli ad epiloghi anche catastrofici (link).
Non avevo mai fatto i conti con questa parte di me, eppure ho capito che senza la possibilità di poter toccare anche solo un braccio di un altro essere umano io non so stare. È una mia debolezza o una mia forza? Non lo so e non me lo pongo certamente come un problema, eppure così è e se c’è una cosa che ho ulteriormente capito è che non bisogna dar per ovvio nulla, neanche l’esistenza di un abbraccio.
Di questo sono grato al lockdown, perché tra le mille miserie che mi ha lasciato intorno, è grazie ad esso se oggi, quando abbraccio qualcuno lo faccio dandoci l’attenzione che merita.
Ricordo benissimo la prima persona che abbracciai dopo quel duro isolamento: non potei chiedere di meglio per ricominciare.
Nessuno mi può giudicare, nemmeno tu. Aggrappare le proprie scelte e, in certi casi, la propria esistenza sulla Terra ai giudizi degli altri è un rischio che si corre e in cui spesso ci ritroviamo inconsapevolmente. Io non sono da meno. Eppure, nel corso del tempo ho cercato il modo di fuggire da questa ragnatela, perché essere imbrigliato e non riuscire a muoversi come si vuole non è una sensazione appagante, neanche se ci si abitua.
Potrei parlare di “coraggio delle proprie scelte”, ma provo a farla più semplice e meno retorica: vivere una vita che non è propriamente nostra al 100% non ci rende più affabili agli occhi del mondo e delle persone che ci circondano, neanche di coloro verso i cui giudizi mostriamo particolare attenzione. Le persone cambiano e con loro anche i giudizi che esprimono.
Oggi, veniamo giudicati perché abbiamo fatto una cosa mentre, domani, potremo essere giudicati dallo stesso soggetto per non averla fatta. Dunque, perché sforzarsi di piacere agli altri, a tutti i costi, cercando un disperato ritorno di accettazione?
Pochi giorni fa è venuta a mancare Michela Murgia. Tra le tante ricchezze che ci ha lasciato in eredità, mi ha sempre colpito quella sua capacità di essere stata sé stessa con le parole e con le azioni. In uno dei suoi ultimi interventi pubblici, durante l’ultima edizione del Salone del Libro di Torino, aveva affermato: “Io sto vivendo il tempo della mia vita adesso. Dico tutto, faccio tutto, tanto che mi fanno? Mi licenziano? […] Ma voi non aspettate di avere un cancro per fare così” (video).
“Tanto cosa mi fanno?”. Il senso è tutto in questa domanda. Se ci ponessimo l’obiettivo di vivere la nostra vita come desideriamo davvero, sono certo che la risposta a quella domanda potrebbe essere, semplicemente, una: niente. Non possono farmi niente. E se qualcuno si allontanasse da me per aver fatto una scelta che sentivo davvero mia, vuol dire che aveva proiettato su di me aspettative completamente sconnesse con la mia persona, e generalmente frutto di superficialità nel conoscere chi si ha davanti o, peggio, di arroganza nel credere di poter condizionare le azioni dell’altro proprio attraverso l’idea che si ha di lui.
Ma noi siamo più di quello che gli altri pensano di noi. Ecco perché se voglio comprarmi qualcosa, lo faccio perché a me va. Se voglio parlare di un argomento delicato, lo faccio perché a me va. Se voglio raccontare qualcosa che mi riguarda, lo faccio perché a me va. Se voglio farmi un orecchino, lo faccio perché a me va.
Questo approccio che io applico su me stesso vorrei poterlo traslare, in chiave di reciprocità, verso i rapporti che io ho con gli altri. Certo è che non si tratta di un lavoro semplice, soprattutto perché bisogna essere almeno in due ad accettare questa visione delle cose. Non c’è dubbio, però, che sia meglio tentare e dire di aver fallito, piuttosto che teorizzare cose che restano solo dei desiderata o dei principi inapplicati.
I “mai” sono scritti sulla sabbia. Faccio un mestiere – quello dell’avvocato – da quasi 6 anni. Un destino professionale che, durante l’università, giuravo a me stesso (e agli altri) di voler evitare. “Forse, come ultima spiaggia”, dicevo. Eppure, da ultima spiaggia è diventata la prima. Non mi ha costretto nessuno a farlo né, tantomeno, qualcuno mi costringe ora. L’insegnamento che traggo da come sono andate le cose, in questi anni, è che non bisogna partire con il pregiudizio che qualcosa non ci piaccia o con anatemi scagliati contro quelle che, tutto sommato, restano delle ipotesi plausibili. Se non abbiamo provato cosa significhi percepirsi in una certa dimensione, anche per un solo giorno, come possiamo darvi un giudizio così netto e a priori? Potessi tornare indietro nel tempo, direi al me universitario che i “mai” sono scritti sulla sabbia e che alla prima mareggiata tutto si cancella. E avrei aggiunto che quel mestiere lì poi, alla fine, avrà il suo fascino e che non sarà proprio come se lo immagina lui.
Cosa mi riserverà il futuro è impossibile che io lo possa sapere (e anche basta a doverselo chiedere, che poi l’unica cosa che si ottiene è l’ansia che sale), ma mi riservo di dire che oltre al “mai”, non esiste neanche il “per sempre” e che l’idea di assumere tante forme, nella propria vita, ti permette di approcciarti alle cose attuali con un grado di serenità maggiore e con la forza di chi sa di star facendo il suo ruolo nella rappresentazione dei propri giorni e di quelli degli altri. Per quanto siamo e dobbiamo essere i protagonisti della nostra opera teatrale di cui sopra, ricordiamoci che siamo anche parti (secondarie, con buona pace degli egocentrici) di quelle degli altri.
A chi, alla fine di questo post, si sia chiesto: sì, ma a questi 30 anni ci sei arrivato felice o lacerato nell’animo? Rispondo che sono uno scontento felice. Contento, deriva dal latino, contentus (participio passato di continere) e significa appagato, soddisfatto di ciò che si fa o si riceve. Ed io non sono soddisfatto di ciò che ho fatto e ho ricevuto fino ad ora, perché so di poter e dover ancora fare molto. Però sono felice (dal latino felix, non turbato da dolori), perché sono sereno e so di spingere l’accelleratore quando posso e di star crescendo, obtorto collo.
Grazie. A chi è arrivato fin qui (ed è sopravvissuto a questo post). E a chi c’è stato fino ad ora e a chi ci sarà.
Cheers!